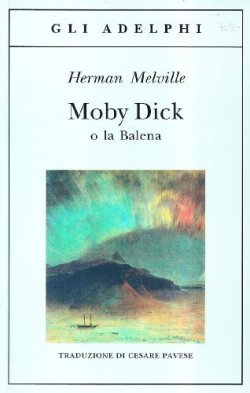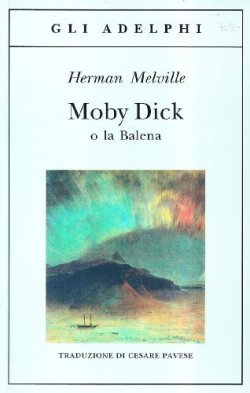
Moby Dick, opera leggendaria, viene pubblicato nel 1851 e rimane il capolavoro indiscusso di Herman Melville.
Il romanzo assume a tratti le forme di: libro d’avventura, manuale per la caccia alle balene, dizionario, memorandum, saggio d’introspezione psicologica, racconto epico, trattato epistemologico, filosofico, artistico o semplicemente linguistico; l’autore utilizza un numero impressionante di digressioni prese dai libri di storia, testi antichi e suoi contemporanei, Shakespeare, La Bibbia. Moby Dick è un lunghissimo inno al mistero della vita.
Ismaele, narratore e testimone, si imbarca sulla baleniera “Pequod”, il cui capitano è Achab. Il capitano ha giurato vendetta a Moby Dick, una immensa balena bianca che, in un viaggio precedente, gli aveva troncato una gamba. Inizia un inseguimento per i mari di tre quarti del mondo. Lunghe attese, discussioni, riflessioni filosofiche, accompagnano l’inseguimento. L’unico amico di Ishmael morirà prima della fine della vicenda. E’ Queequeg, un indiano che si era costruito una bara intarsiata con strani geroglifici. Moby Dick viene infine avvistata e arpionata. Trascinerà nell’abisso lo stesso Achab, crocefisso sul suo dorso dalle corde degli arpioni. Ishmael è l’unico che sopravvive, usando, come zattera, la bara di Queequeg.
Un romanzo impegnativo, lungo, ma molto bello; mi ha catturata e commossa.
Moby Dick è stato tradotto in italiano per la prima volta proprio da Cesare Pavese, nel 1932. Egli fu scopritore e divulgatore dei miti della letteratura anglo-americana, ma anche traduttore originale, “vero”, personalistico. Pavese traduce il senso del romanzo di Melville come lo percepisce lui, perché tutta la sua letteratura, fatta di racconti e poesie, ne è intrisa dello stesso senso (nonostante un secolo di vita dividesse lui da Melville).
Tradurre Moby Dick è un mettersi al corrente con i tempi. Il libro – ignoto sinora in Italia – ha tacitamente ispirato per tutta la metà del secolo scorso i maggiori libri di mare. E da qualche decina di anni gli anglo-sassoni ritornano a Melville come a un padre spirituale scoprendo in lui, enormi e vitali, i molti motivi che la letteratura esoticheggiante ha poi ridotto in mezzo secolo alla volgarità. Herman Melville, nato a New York nel 1819 da una famiglia antica e nobilesca, morì a New York nel 1891, dopo essere passato anche per gli impieghi statali, immiserito, sconosciuto e sdegnoso. Ma queste sue infelicità non ci toccano. È la solita sorte dei grandi, su cui piace ai posteri spargere eloquenza, salvo poi a trattare anch’essi i contemporanei nell’antichissimo modo. Questa infelicità di Melville anzi ha avuto qualche parte in Moby Dick. Benvenuto, quindi. Poi bisogna ricordare i quattro anni della giovinezza passati su navi baleniere e da guerra, nel Pacifico, nell’Atlantico, tra cacce, tifoni, bonacce e avventure d’inferno o d’arcadia, tutta materia che è stata colata, con un lento lavoro di assimilazione, nelle opere. E l’arcadia c’è in Typee, c’è in Omoo, c’è in Mardi, le storie ispirate dai mesi di vita che l’autore condusse in comune coi cannibali di un’isola oceanica. L’inferno è in WhiteJaeket – spigliato e spietato giornale della vita di bordo su una nave da guerra – e in Pierre, una truce storia morale fallita, che serve a mostrare a quale prezzo, e con quali fatiche l’autore di Moby Dick sia giunto al capolavoro.
Ottobre 1941, Cesare Pavese
Capitolo I
Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa – non importa quanti esattamente – avendo pochi o punti denari in tasca e nulla di particolare che m’interessasse a terra, pensai di darmi alla navigazione e vedere la parte acquea del mondo. E’ un modo che ho io di cacciare la malinconia e di regolare la circolazione. Ogni volta che m’accorgo di atteggiare le labbra al torvo, ogni volta che nell’anima mi scende come un novembre umido e piovigginoso, ogni volta che mi accorgo di fermarmi involontariamente dinanzi alle agenzie di pompe funebri e di andar dietro a tutti i funerali che incontro, e specialmente ogni volta che il malumore si fa tanto forte in me che mi occorre un robusto principio morale per impedirmi di scendere risoluto in istrada e gettare metodicamente per terra il cappello alla gente, allora decido che è tempo di mettermi in mare al più presto. Questo è il mio surrogato della pistola e della pallottola. Con un bel gesto filosofico Catone si getta sulla spada: io cheto cheto mi metto in mare. Non c’è nulla di sorprendente in questo. Se soltanto lo sapessero, quasi tutti gli uomini nutrono, una volta o l’altra, ciascuno nella sua misura, su per giù gli stessi sentimenti che nutro io verso l’oceano.
Eccovi dunque la città insulare dei Manhattanesi (il nome indiano di New York, ndr) circondata da banchine, come le isole indiane da scogliere di coralli: il commercio la cinge con la sua risacca. A destra e a sinistra le vie vi conducono al mare. Il suo punto principale è il Bastione, dove quella mole illustre è ventilata dalle brezze e bagnata dalle onde che poche ore prima erano fuori vista da terra. Guardate la folla dei contemplatori dell’acqua.
Andate in giro per la città in un sognante pomeriggio del Sabato. Andate al Corleas Hook a Coenties Slip e di là, lungo Whitehall, verso il nord. Che cosa vedete? Fissi, come sentinelle silenziose, tutto intorno alla città stanno migliaia e migliaia di mortali perduti in fantasticherie oceaniche. Alcuni appoggiati a una palizzata, altri seduti sulle testate dei moli, altri che guardano oltre le murate di navi che provengono dalla Cina e altri arriva, nell’attrezzatura, come se si sforzassero di gettare un’occhiata ancor più vasta, verso il mare. Ma tutti costoro sono gente di terra; rinchiusi, nei sedili, avvinti alle scrivanie. Come va dunque? Sono scomparse tutte le verdi campagne? Che cosa fanno qui costoro?
Ma, ecco! ecco che giungono altri gruppi, che van diritti all’acqua e con l’intenzione, pare, di fare un tuffo. Strano! Nulla li soddisfa, se non il limite estremo della terraferma; gironzare all’ombroso sottovento di quei magazzini non basta. No. Bisogna ch’essi s’avvicinino all’acqua quant’è possibile senza caderci dentro. Ed eccoli là fermi, per miglia e miglia, per leghe. Gente dell’interno tutti, vengono da viottoli e da vicoli, da vie e da corsi, dal nord, dall’est, dal sud e dall’ovest. E pure qui s’uniscono tutti. Ditemi, forse il potere magnetico degli aghi delle bussole di tutte quelle navi li attira qui?
Ancora. Voi siete in campagna, su qualche altopiano, lacustre. Prendete qualsiasi sentiero vi piaccia e, nove volte su dieci, questo vi conduce in una valle e vi lascia lì, acanto a uno stagno formato dalla corrente. C’è del magico in questo. Che il più distratto degli uomini sia immerso nelle sue più profonde fantasticherie: mettete quest’uomo in piedi, fategli muovere le gambe, ed egli, infallibilmente, vi condurrà all’acqua, se acqua c’è in tutta la regione.. Se vi succedesse mai di restare assetati nel gran deserto americano, provate l’esperimento, dato che la vostra carovana sia eventualmente fornita di un professore di metafisica. Sì, come ciascuno sa, acqua e meditazione sono sposate per sempre.
Ma prendete un artista. Egli desidera dipingere il più sognante, il più ombroso, il più tranquillo, il più incantevole paesaggio romantico di tutta la vallata del Saco. Qual è l’elemento essenziale che adopera? Ecco i suoi alberi, ciascuno col tronco cavo, come se dentro ci fossero un eremita e un crocefisso; ecco, qui dorme il fraticello e là dorme il gregge, e su da quella casetta s’innalza un fumo sonnacchioso. Lontano, in remote boscaglie, si sprofonda una strada serpeggiante, fino ai sovrastanti speroni di monti immersi nell’azzurro delle loro coste. Ma per quanto la scena giaccia così estatica e il pino scuota giù i sospiri, come le foglie, sulla testa del pastore, tutto sarebbe invano, se l’occhio del pastore non fissasse la magica corrente che ha davanti. Andate a visitare le praterie in giugno, quando, per ventine di miglia, voi sprofondate fino al ginocchio nei gigli tigrati: qual è l’unica dolcezza che manca? L’acqua: non c’è una goccia d’acqua in quei luoghi! Se il Niagara fosse soltanto una cascata di sabbia, lo fareste voi quel viaggio di mille miglia per andare a vedere? Perché il povero poeta del Tennessee (ndr Pavese: credo che alluda a quel sarto Edward J. Billings nominato anni dopo da Mark Twain nel Captain Stormfield’s Visit to Heaven) ricevendo improvvisamente due manciate d’argento, stette a deliberare se comprarsi un vestito, di cui aveva terribilmente bisogno, o investire il denaro in un viaggio a piedi fino alla spiaggia del Rockaway? Perché quasi ogni ragazzo sano e robusto, che abbia dentro in se uno spirito sano e robusto, prima o poi ammattisce dalla voglia di mettersi in mare? Perché al tempo del vostro primo viaggio come passeggero, avete sentito in voi un tal brivido mistico, non appena vi hanno detto che la nave e voi stesso eravate fuori vista da terra? Perché gli antichi Persiani tenevano il mare per sacro? Perché i Greci gli fissarono un dio a parte, e fratello di Giove? Certamente tutto ciò non è senza significato. E ancora più profondo di significato è quel racconto di Narciso, non potendo stringere l’immagine tormentosa e soave che vedeva nella fonte, vi si tuffò e annegò. Ma quella stessa immagine noi la vediamo in tutti i fiumi e negli oceani. Essa è l’immagine dell’inafferrabile fantasma della vita; e questo è la chiave di tutto.
Ora, quando io dico che ho l’abitudine di mettermi in mare tutte le volte che comincio a vedermi una nebbia innanzi agli occhi e a sentire troppo i miei polmoni, non intendo inferire ch’io mi metta in mare come passeggero. Poiché a imbarcarsi come passeggero, bisogna di necessità avere un portafoglio, e un portafoglio è soltanto uno straccio, se non c’è qualcosa dentro. D’altra parte i passeggeri soffrono il mal di mare, diventano litigiosi, non dormono la notte, in generale non si divertono gran che: no, io non mi imbarco mai come passeggero e nemmeno, sebbene io non sia poi un marinaio d’acqua dolce, come commodoro, come capitano, o come cuoco. Abbandono la gloria e la distinzione di tali uffici a quelli che li vogliono. Da parte mia, ho in abominio tutte le onorevoli e rispettabili fatiche, difficoltà e tribolazioni, di qualunque genere esse siano. Prender cura di me stesso, senza curarmi delle navi, dei brigantini a paolo, dei brigantini semplici, delle golette che so io, è tutto quanto so fare. E quanto a impiegarmi da cuoco – sebbene, lo confesso, ci sia in questo una considerevole gloria, il cuoco essendo, a bordo, una specie di ufficiale – pure, arrostire i polli non è mai stato il fatto mio; sebbene una volta che il pollo sia ben arrostito, giudiziosamente imburrato e criticamente salato e pepato, non ci sarà nessuno che ne parlerà con più rispetto, per non dire reverenza, di me. E’ a motivo delle idolatre infatuazioni degli antichi Egizi a proposito di ibis e di ippopotamo arrosto che si possono vedere le mummie di queste creature in quei loro grandi forni che sono le piramidi.
No, quand’io mi metto in mare, lo faccio da semplice marinaio, ben dinanzi all’albero, ben giù nel castello e bene arriva alla testa d’alberetto. E’ vero, mi dànno un bel po’ di ordini e mi fanno saltare sulle manovre, come una cavalletta a maggio in un prato. E, sulle prime, la faccenda è abbastanza spiacevole. Tocca una persona nell’onore, specialmente se accade che questa persona discenda da una vecchia famiglia residente, i Van Rensselaers o i Randolphs o gli Hardicanutes. E più che tutto vi succede se, soltanto un poco prima di cacciar le mani nel secchiello del catrame, voi l’avete fatta da padrone in qualità di maestro di scuola in campagna, dove i ragazzi più grandi vi stavano innanzi come al nume. E’ forte il passaggio, ve l’assicuro, da maestro di scuola a marinaio, e richiede una robusta alimentazione a base di seneca e di Stoici, per mettervi in grado di sorriderci e sopportarlo. Ma anche questo col tempo dà giù.
Che cosa importa se qualche spilorcio di un capitano mi comanda di andare a prendere la scopa e strofinare i ponti? Che cosa conta più quest’indegnità pesata, poniamo, con le bilance del Nuovo Testamento? Credete che l’Arcangelo Gabriele li ritenga da meno perché io ubbidisco con prontezza e rispetto in questo particolare accidente a quel vecchio spilorcione? Chi non è schiavo al mondo? Rispondetemi a questo. E dunque, per quanto il vecchio capitano mi dia ordini su ordini, per quanto io riceva pugni e punzonate, io ho la soddisfazione di sapere che tutto va bene, che ogni uomo è, in un modo o nell’altro, servito esattamente alla stessa maniera, voglio dire, da un punto di vista fisico o da uno metafisico, e così l’universale punzonatura va attorno e tutti dovrebbero fregare la schiena l’uno all’altro e restare soddisfatti.
Ancora, io mi metto sempre in mare come marinaio, perché così si fanno un dovere di pagarmi per il disturbo, mentre ai passeggeri, che io sappia, non pagano mai neanche un soldo. Al contrario, i passeggeri devono pagare loro. Ed ecco tutta la differenza al mondo tra pagare e venir pagato. L’atto di pagare è forse la condanna più seccante che i due ladri del fruttetto ci abbiano lasciato in eredità. Ma “venir pagato”, che cosa c’è di comparabile al mondo? La cortese avidità con cui un uomo riceve il denaro è veramente meravigliosa, se si pensa che noi siamo così profondamente convinti che il denaro è la radice di tutti i mali terreni e che, a nessun patto, può un uomo danaroso entrare nel cielo. Ah, con quanta allegrezza noi ci buttiamo nella perdizione!
Finalmente, io mi metto sempre in mare come marinaio, per via del sano esercizio e dell’aria pura che si gode sul ponte di prora. Poiché, siccome in questo mondo i venti contrari prevalgono di gran lunga sui venti di poppa (e questo, se voi non offendete la massima pitagorica), così il più delle volte il commodoro sul cassero riceve di seconda mano l’aria dai marinai del castello. Egli crede di respirarla per primo, ma non è così. In modo consimile le comunità guidano i loro capi in molte altre cose, nel tempo stesso che i capi nemmeno lo sospettanto. Ma per quale ragione io, che avevo ripetutamente sentito l’odore del mare in qualità di marinaio mercantile, dovessi ora cacciarmi in testa di partire per un viaggio a balene, a questo l’invisibile questurino dei Fati, che è incaricato della mia costante sorveglianza e che segretamente mi tien dietro come un cane e in qualche modo inspiegabilmente mi trasmette i suoi influssi: a questo puù rispondere lui meglio di chiunque altro. E senza dubbio la mia partecipazione a questo viaggio baleniero era parte del gran programma che la Provvidenza tracciò tanto tempo fa. Esso entrava come una specie di breve intermezzo e assolo tra numeri molto più estesi. M’immagino che quel tratto del cartello dovesse suonare pressappoco così:
Grande dibattito elettorale per la presidenza
degli Stati Uniti
Viaggio a balene di un certo Ismaele
Sanguinoso combattimento nell’Afghanistan
Quantunque io non sappia dire la ragione esatta perché quei direttori di scena, che sono i Fati, abbiano voluto affidarmi questa meschina parte di una crociera a balene, mentre altri vennero designati a magnifiche parti in elevate tragedie, a parti brevi e facili in signorili commedie e a gaie parti in farse, quantunque io non sappia dirne la ragione esatta, pure, ora che mi richiamo tutte le circostanze, credo di vederci un poco tra le molle e i motivi che, venendomi astutamente presentati sotto vari travestimenti, m’indussero a darmi d’attorno e recitare la parte che recitai, oltre a lusingarmi nell’illusione che questa fosse una scelta risultante dal mio spregiudicato libero arbitrio e dal mio discernimento.
Essenziale tra questi motivi era la travolgente idea della grande balena in carne e ossa. Un mostro tanto portentoso e misterioso sollevava tutta la mia curiosità. Poi, i mari selvaggi e remoti dov’egli voltolava la sua massa simile a un’isola, i pericoli, indescrivibili e senza nome, della caccia: queste cose, con tutte le concomitanti meraviglie di un migliaio di parvenza e di suoni patagonici, s’aggiungevano a spingermi al mio desiderio. Ad altri uomini, forse, tutto questo non sarebbe stato d’incitamento, ma, quanto a me, io sono tormentato da una smania sempiterna per le cose lontane. Mi piace navigare mari proibiti e approdare su coste barbariche. Non ignorante di ciò che è bene, sono lesto a percepire un orrore, ma non per questo, se ci riesco gli volto le spalle; dato che non è che bene mantenersi in buoni rapporti con gli inquilini del luogo dove si abita.
Per tutte queste cose, dunque, il viaggio a balene fu il benvenuto: le grandi cateratte del mondo delle meraviglie si spalancarono e, nelle selvagge fissazioni che mi spinsero al mio proposito, a due a due fluttuavano nel mio spirito infinite processioni di balene e, in mezzo a tutte, un grande fantasma incappucciato, simile a una collina di neve nell’aria.
Herman Melville, Cap. I di Moby Dick – Traduzione di Cesare Pavese